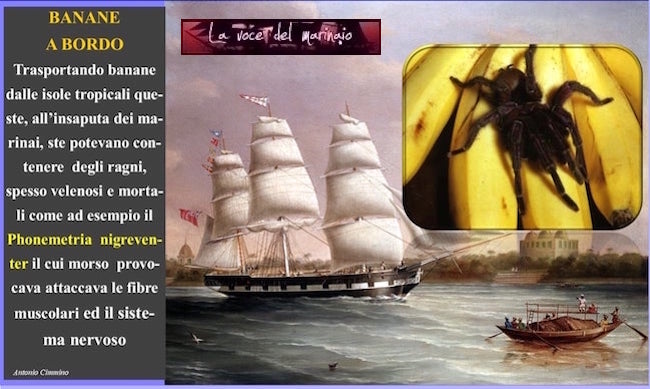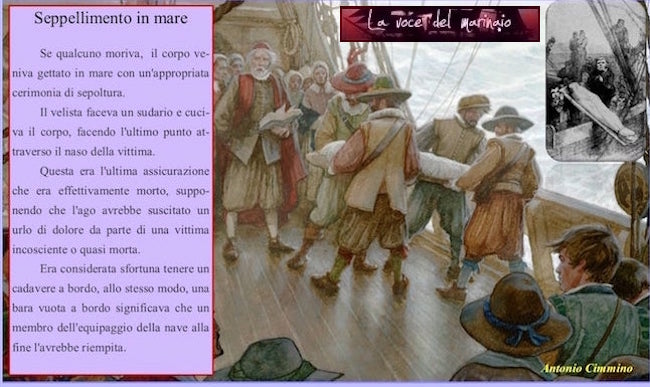Curiosità
-
10.10.1855, impostazione avviso a ruote Sirena
di Antonio Cimmino
La nave
Con il termine avviso, nella marineria velica si designava una piccola unità armata a cutter, usata come trait-d’union, per posta o ordini, tra le navi delle squadre navali ovvero con la base. Con l’introduzione del vapore, questi avvisi si dotarono anche di macchine alternative, unitamente all’armamento velico, con ruote laterali di propulsione e, più tardi, con elica. L’ingombro delle caldaie e delle motrici, era consistente tanto è vero che i due alberi (trinchetto e maestro) erano distanti l’uno dall’altro. La velatura era necessaria per la scarsa affidabilità dei macchinari che, d’altronde, consumavano una enorme quantità di carbone. L’avviso aveva anche il compito di trainare i vascelli e le altre navi a vela, in caso di bonaccia.
Pur non essendo adeguatamente armati e quindi atti al combattimento, gli avvisi erano utilizzati nelle esplorazioni essendo più veloci delle navi a vela. La velocità era favorita da un buon disegno dello scafo, molto lungo e stellato. Nella seconda metà dell’800 le loro dimensioni aumentava avviandosi a divenire corvette a vapore ovvero piccoli incrociatori.
Durante il periodo borbonico, il cantiere di Castellammare costruì diverse unità di questo tipo, alcune protagoniste della storia dei primordi della Regia Marina (Delfino, Maria Teresa, Lilibeo, Messaggero, Miseno).
Caratteristiche tecniche
– Impostato nel cantiere navale di Castellammare di Stabia il 10 ottobre 1855;
– Varato il 9 novembre 1859;
– Entrato in servizio nella Marina borbonica il 28 maggio 1860;
– Scafo in legno con carena ramata;
– Dislocamento a pieno carico: 427 tonnellate; normale pari a 354 tonn.;
– Dimensioni: metri 45,0 lunghezza fra le perpendicolari; metri 6,8 larghezza e metri 2,7 di immersione.
Apparato motore:
– 2 caldaie a tubi d’acqua collegate ad una macchina alternativa a vapore tipo Maudslay & Field a bassa pressione;
– potenza 120 cavalli; ruote di propulsione laterali che imprimevano una velocità di 12 nodi. Due alti fumaioli favorivano il tiraggio
Apparato velico del tipo brigantino-goletta: albero di trinchetto a vele quadre ed albero maestro a vele auriche (trapezoidali).
Armamento originario: 1 cannone in ferro a canna liscia da 60 libbre;
Equipaggio:
– 1 Tenente di Vascello quale comandante,
– 1 Allievo di Vascello, 1 Pilota, 1 Chirurgo, 1 Pratico di chirurgia, 1 Tenente di Fanteria Marina, 3 Piloti, 1 Nostromo, 1 Guardiano, 2 Timonieri, 18 Marinai, 1 Contestabile, 1 Sergente cannoniere, 10 Cannonieri, 1 Sergente di Fanteria Marina,1 Tamburo, 22 Fanti di Marina, 1 Macchinista, 3 Alunni macchinisti, 4 Carbonai, 3 Maestri d’ascia, 1 Calafato, 1 Maestro razione, 1 Dispensiere, 1 Cuoco, 5 Domestici.
Storia
Radiato dal naviglio da guerra nel giugno del 1884 e adibito a deposito munizioni a Miseno fino al 1884. Successivamente fu utilizzato come guardaporto a Napoli con la sigla G.M.8. Nel 1910 fu venduto ai privati per 5.100 lire per la demolizione.
Armamento bellico all’atto del passaggio alla Regia Marina
– 1 cannone in ferro ad anima liscia ad avancarica da 200 mm caricato con bombe da 30 libbre;
– 1 cannone di bronzo ad anima liscia da 160 mm di calibro e caricato con palle da 24 libbre.
Armamento del 1872
– 2 cannoni in bronzo con anima liscia da 80 libbre;
– 2 cannoni in bronzo con anima liscia da 75 libbre.
Attività operativa
L’unica azione effettuata sotto la bandiera borbonica fu quella di rimorchiare a Palermo, al comando del Tenente di vascello Roberto Pucci, il brigantino San Girolamo.
Il 7 agosto 1860, al comando del Capitano di fregata Pietro Lavia, non obbedì all’ordine di seguire Francesco II e fu aggregata alla squadra sarda del Contrammiraglio Persano passando al comando del Capitano di fregata Leopoldo de Cosa.
Il 24 gennaio del 1861 la nave fu inviata nel Canale di Otranto per la sorveglianza della posa del cavo sottomarino da Brindisi per Corfù ad opera della nave inglese William.
Tornata a Messina, il 17 marzo fu iscritto nel naviglio da guerra del Regno d’Italia e classificato “piroscafo a ruote” e, nel 1863, riclassificato “ avviso a ruote di 2° ordine”.
Dopo diverse evoluzioni nel Tirreno e dopo essere posta in disarmo, la nave fu riarmata il 18 gennaio del 1864 e posta a Spezia, a disposizione del Contrammiraglio Provana del Sabbione prima e del Contrammiraglio Augusto Riboty poi. Fu destinata alla protezione degli interessi nazionali nelle acque della Tunisia al comando del Capitano di Fregata Giribaldi. Disarmata diverse volte ed altrettante volte riarmata, fece spola tra Napoli, Messina e Taranto al comando del Capitano di Fregata Raffaele Noce.
Il 16 marzo del 1866 al comando del Luogotenente di Vascello Sanminiatelli fu destinata nel Mar Nero e stazionò a Costantinopoli e nell’anno successivo, al comando del Luogotenente di Vascello Vitagliano operò nello Ionio e nell’Egeo.
Il Sirena tornò a Costantinopoli, al comando del Luogotenente di Vascello Vincenzo Casamarte, nel febbraio del 1868 e, rientrato a Napoli l’anno successivo, rimase in disarmo per circa tre anni.
Nel 1878 fu inviato per la terza volta a Costantinopli durante il conflitto russo-turco. Nel 1880 passò al comando del Capitano di Corvetta Francesco Chigi e l’anno successivo di Luigi Palumbo. In tale periodo operò nelle acque tunisine.
Fino al settembre del 1883 prestò servizio di vigilanza sanitaria nelle acque della Sicilia orientale e, nel mese di ottobre, ritornò a Napoli per il definitivo disarmo.
Comandanti
1860 Capitano di Vascello Pietro Lavia
1863 Luogotenente di Vascello Edoardo Giribaldi
1865 Capitano di Fregata Raffaele Noce
1866 Luogotenente di Vascello Samminiatelli
1866 “ “ Vitagliano
1868 “ “ Vincenzo Casamarte
1880 Capitano di Corvetta Luigi Palumbo
Notizie e curiosità
Il Reggimento di Fanteria di Marina, la cui fondazione risale a Carlo di Borbone Re di Napoli (dal 1734-1759), accompagnò tutta la vita del regno delle Due Sicilie e, persino durante il periodo Napoleonico-Murattiano (dal 1806-1808 Giuseppe Bonaparte e dal 1808 al 1815 Gioacchino Murat) esistette a Napoli un Reparto analogo di marinai e cannonieri della guardia a similitudine dei “Marine de la Garde” Napoleonici. Durante la permanenza di Re Ferdinando (Re dal 1759-1815) in Sicilia, con alterne vicende dal 1799 al 1815, parte del Reparto rimase a seguito dello stesso. Durante tale periodo, unità del Reggimento operarono dalla Sicilia a fianco dei “Royal Marines” britannici (Spedizione a Malta nel 1800, riconquista delle isole di Ischia e Procida nel 1809, Battaglia di Maida nel 1806 etc..). Dopo il periodo napoleonico, con la Restaurazione, il Reparto subì varie riforme, assumendo consistenza diversa a secondo dei momenti, arrivò ad avere un organico di due Battaglioni di sei compagnie per un totale di 2400 Fanti di Marina ed unitamente al Reggimento Cacciatori della Guardia Reale costituiva una delle Brigate della “Guardia Reale”. Il periodo di maggiore splendore coincise con il lungo regno di Ferdinando II (1830-1859).
Il Reggimento di Fanteria di Marina si occupava della difesa a terra delle basi navali ed a bordo delle navi forniva il supporto di fucileria nei combattimenti ravvicinati e negli abbordaggi oltre ovviamente a costituire l’avanguardia nelle operazioni di sbarco. Una delle operazioni più impegnative che lo vide protagonista fu l’operazione anfibia per la riconquista della Sicilia nel 1849 (sbarco nei pressi di Messina). Il Reggimento concluse la sua vita organica negli ultimi giorni di permanenza di Re Francesco II (Re dal 1859-1861) a Napoli ed elementi del Reparto furono presenti all’eroica difesa della città di Gaeta... Il calibro dei cannoni è espresso in mm e rappresenta il diametro della bocca mentre le libbre sono il peso della palla. Una libbra (inglese) equivale a 453,8 grammi mentre la libbra dei cannoni francesi equivala a circa 500 grammi.
..la Guerra turco-russa del 1877-78 ebbe origine dalla volontà russe di ottenere uno sbocco sul Mar Mediterraneo e di liberare le popolazioni slave residenti nei Balcani occupati dall’Impero Ottomano. Le potenze occidentali, tra cui anche l’Italia approfittarono della situazione per chiedere al sultano di concedere ampia libertà di culto alle chiese cristiane dell’Impero Ottomano.
Cenni di architettura navale e marineria
La lunghezza fra le perpendicolari è quella intercorrente tra la verticale del dritto di prora in corrispondenza della linea di massimo galleggiamento e la verticale che passa per l’asse di rotazione del timone a poppa.
Le ruote di propulsione furono introdotte nella costruzione navale nel 1830 dall’inglese William Morgan. Alla periferia delle due ruote erano sistemate delle palette ruotanti sul loro asse e, con un sistema di assi eccentrici, quando la ruota gira le palette assumono, rispetto all’acqua, una posizione variabile rispetto alla verticale. Tale sistema, assieme a quello che prevedeva le pale perfettamente verticali ed a quello delle ruote a pale fisse radiali, risultò poco efficiente ed agevolò lo studio e l’introduzione dell’elica. Le ruote di propulsione laterali, inoltre, in caso di rollio risultavano fuori dall’acqua una volta sinistra ed una volta a dritta e le palette non potevano imprimere una spinta simultanea per cui il governo della unità era abbastanza difficoltoso.
Con un carico di carbone di 50 tonnellate ad una velocità di 12 nodi, il Sirena aveva una autonomia di 12 miglia. (1 miglio marino era di circa 1852 metri) per cui abbisogna di continui rifornimenti di combustibile. Per questo motivo furono attrezzati diversi porti del Regno delle Due Sicilie per sopperire a tale necessità.
L’albero di bompresso è quello non verticale, sporgente fuori prua, su cui si estende il lato inferiore delle vele triangolari dette fiocchi. Se grande, si compone di tre parti: la maggiore (bompresso) fissata alla prua; la mediana sovrapposta (asta di fiocco); la terza risovrapposta (asta di controfiocco).
L’albero di trinchetto è di solito composto da 4 parti denominate, partendo dal ponte: fuso maggiore di trinchetto, albero di parrocchetto, alberetto di velaccino, alberetto di controvelaccino.
L’albero di maestra, anch’esso formato da 4 parti denominate, sempre partendo dal ponte: fuso maggiore di maestra, albero di gabbia, alberetto di gran velaccio, alberetto di controvelaccio.Fonti
AA.VV., Esploratori, fregate, corvette ed avvisi italiani 1861-1968, Ufficio storico della Marina, 1969:
AA.VV. Navi da guerra/RN Sirena 1859, in www.agenziabozzo.it
AA.VV. Muadslay and Filed, in www.history.rochester.edu/steam/lardner/chap13.html – 87k.
AA.VV., Battello Patria-Scheda tecnica, in www.como.polimi.it/Patria/testi/scheda.htm.
AA.VV., Real Marina del Regno delle Due Sicilie, in it.wikipendia.org/wiki/Real_Marina_del_Regno_delle_Due_Sicilie-89k.
AA.VV., Il glossario della marineria d’altri tempi, in www.correrenelverde.com/nautica/glossario/glossario.htm – 273k.
AA.VV., Cannone di bronzo, in www.earmiit/cannon1.htm-3k
Musciarello L., Dizionario delle armi, voce calibro, Oscar Modadori, Milano, 1978
Radogna L., Cronistoria delle unità da guerra delle Marine preunitarie, Vol.11, Uff.Storico della M.M., 1981, pagg. 263-265 -
La posta di BETASOM
di Guglielmo Evangelista (*)
 Di Betasom, la Base Atlantica di Bordeaux dei nostri sommergibili, si è parlato tantissimo, ma non si è detto tutto.
Di Betasom, la Base Atlantica di Bordeaux dei nostri sommergibili, si è parlato tantissimo, ma non si è detto tutto.
Come comunicavano con casa i nostri marinai? Oltre alla cartoline di franchigia potevano anche scrivere lettere più lunghe o usufruire a tariffa di tutti i servizi postali come pacchi, vaglia e raccomandate.
Ovviamente scrivevano, e le lettere erano lunghe complice il maggior tempo libero per il personale non imbarcato.
Nella base era stato aperto uno spaccio che vendeva anche francobolli e funzionava un servizio postale diretto con l’Italia.
La nostra posta viaggiava approfittando della Feldpost, la posta militare tedesca che, come d’uso, per anni h provveduto a inoltrarla a Roma, al Ministero; dopo l’8 settembre compaiono anche dei corrieri, sottufficiali o marinai che raggiungevano La Spezia per servizio e da dove poi la corrispondenza veniva smistata in tutta l’Italia del nord. Questo sistema si rivelò molto più rapido dell’inoltro ordinario. L’alleato germanico, in faccende sempre più gravi affaccendato, tollerava.
Nonostante ci si appoggiasse ai tedeschi e Betasom fosse isolata nel territorio da essi occupato, i francobolli usati erano gli stessi delle serie in corso in Italia e, come in Italia, erano soprattutto quelli della serie detta “Imperiale” stampati in milioni e milioni di pezzi ed è difficile che chi conserva qualche vecchia lettera non abbia in casa qualche busta affrancata con questi comunissimi esemplari il cui valore commerciale è di pochi centesimi. I tagli disponibili erano assortiti in relazione alle diverse tariffe che variavano a seconda dell’oggetto postale che veniva inviato.
Dopo l’8 settembre e l’adesione di gran parte del personale alla repubblica di Mussolini, l’attività bellica e logistica riprese rapidamente, compreso il servizio postale.Ritenendo che non fosse più opportuno usare i vecchi francobolli – alcuni portavano l’effige del Re- e ancora senza un’autorità competente a dare disposizioni, fu deciso di mostrare la propria tendenza politica scalpellando dai timbri lo stemma reale e sovrastampando le giacenze disponibili con la dicitura “Italia Repubblicana Fascista-Base Atlantica”.
La soprastampa fu eseguita nella tipografia di bordo del grande transatlantico De Grasse requisito e utilizzato per ospitare caserme, uffici e servizi.
L’ordine fu firmato dal Comandante della base Capitano di Vascello Enzo Grossi. Sembra che lui fosse un collezionista e forse l’iniziativa fu sua, approfittando dell’occasione per lasciare il suo nome anche nella storia postale oltre che in quella navale.
Più tardi, nonostante il nuovo assetto istituzionale stabilito da Mussolini, a Betasom non giunsero mai i francobolli della Repubblica Sociale, né i primi provvisori né quelli definitivi.
Si proseguì quindi utilizzando ancora le abbondanti giacenze, ma usando la nuova soprastampa “Repubblica Sociale Italiana Base Atlantica”.L’ultima lettera conosciuta è dell’11 luglio 1944 quando ormai la base era in via di smobilitazione.
Furono sovrastampati e usati non meno di 200000 francobolli di 17 tipi diversi.
Di fatto non furono considerati emissioni ufficiali, ma furono tranquillamente tollerati dalle autorità postali di Salò e le lettere, al momento in cui arrivavano in Italia, non erano tassate maregolarmente recapitate.
Oggi sono quasi tutti pezzi molto rari, ambiti non solo dai collezionisti italiani ma anche da quelli francesi e tedeschi ed è difficilissimo riuscire a trovarne qualcuno sul mercato. Di eccezionale rarità, praticamente dei pezzi unici, sono le buste complete viaggiate poiché spesso, a fine guerra, furono distrutte per non farsi trovare in casa documenti divenuti improvvisamente compromettenti.
Assieme alle due emissioni regolari di cui abbiamo parlato si registrano sovrastampe false, errori di soprastampa preparati ad arte, sovrastampe su francobolli mai usati a Betasom: fra le tante migliaia di persone della base c’erano in mezzo appassionati filatelici a tutti i livelli che pensarono di crearsi un “tesoretto” e dopo il 1945 vi furono poi molti che specularono sull’interesse venutosi a creare attorno a questi francobolli.
Insomma, si dice che raccogliere francobolli vuol dire portarsi a casa un pezzo di storia, ma in questo caso si tratta di un pezzo di storia che costa caro e che spesso può rivelarsi anche una sgraditissima truffa.(*) per conoscere gli altri suoi articoli digita sul motore di ricerca del blog il suo nome e cognome.
-
Le naumachie
di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra
 Le naumachie erano simulazioni di battaglie navali svolti, in appositi bacini naturali o allagati per la circostanza, a scopo di divertimento, dove si rievocavano famose battaglie storiche.
Le naumachie erano simulazioni di battaglie navali svolti, in appositi bacini naturali o allagati per la circostanza, a scopo di divertimento, dove si rievocavano famose battaglie storiche.
I naumacharii erano in genere prigionieri di guerra o condannati a morte che dovevano guerreggiare indossando le tipiche armature del paese rappresentato, incitati alla lotta dai pretoriani. I combattimenti così diventavano irruenti e davano agli spettatori quell’acre piacere del sangue, come nei ludi gladiatori.
Il termine naumachiae deriva dal greco e indica sia il sito che lo spettacolo, mentre i romani chiamavano queste rappresentazioni “navalia proelia”.
La prima naumachia di cui si ha memoria si tenne a Roma nel 46 a.C. in un lago artificiale creato nel Campo Marzio ad opera di Cesare per celebrare il suo trionfo. In quell’occasione venne simulata la battaglia tra la flotta fenicia e quella egiziana. Parteciparono circa 6.000 figuranti ed una folla enorme giunta dalle vicine colonie accampata nelle strade e nelle piazze, così numerosa come racconta Svetonio, da provocare nella ressa la morte di diverse persone.
 Il pubblico si esaltava alla vista delle navi e delle varie fasi della battaglia proprio perché erano così rare e facevano sfoggio della più raffinata evoluzione tecnica molto più di quella utilizzata negli altri ludi romani.
Il pubblico si esaltava alla vista delle navi e delle varie fasi della battaglia proprio perché erano così rare e facevano sfoggio della più raffinata evoluzione tecnica molto più di quella utilizzata negli altri ludi romani.
Lo scopo dei ludi romani e del loro vasto consenso popolare era quello di tenere il popolo ben nutrito (attraverso la distribuzione gratuita di derrate alimentari a volte integrate con somme di denaro) e ben occupato con sempre maggiori divertimenti e spettacoli per evitare ribellioni e rivolte.
In origine i giochi erano gestiti dai sacerdoti per questioni di culto e duravano, come le famose corse dei cavalli, solo un giorno. Dai 77 giorni di ludi proclamati ufficiali tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’Impero si arrivò nel quarto secolo a ben 177 giorni all’anno dedicati agli spettacoli.
 “Pane et circenses” (pane e divertimento come oppio di massa per gettare interi popoli nell’impotenza politica) era la formula coniata dal poeta satirico Giovenale che se ne servì per stigmatizzare la politica degli imperatori romani nei confronti dei loro sudditi.
“Pane et circenses” (pane e divertimento come oppio di massa per gettare interi popoli nell’impotenza politica) era la formula coniata dal poeta satirico Giovenale che se ne servì per stigmatizzare la politica degli imperatori romani nei confronti dei loro sudditi.
La naumachia di Cesare in effetti aveva stravolto il senso delle proporzioni dello spettacolo per la sua maestosità, per il contenuto storico e soprattutto per l’onerosità dei costi ma ai romani piacque così tanto lo spettacolo che nel corso degli anni si tennero altre di queste rappresentazioni.
Lo stesso Augusto, attento conoscitore delle vicende politiche e del suo popolo, organizzò altre naumachie facendo costruire un grande complesso monumentale circondato da portici ed arricchito da opere d’arte, per lo più bottini di guerra, per celebrare la potenza della flotta romana di suo genero Agrippa (ammiraglio della flotta e costruttore del Pantheon).
Per la prima volta dai tempi di Gaio Duilio, vincitore contro Cartagine, un ammiraglio veniva celebrato più di un generale di terra e per questo motivo l’orgoglio dei romani per la loro flotta veniva raffigurato nella naumachia di Augusto.
Per avere un senso dello proporzioni Augusto e Domiziano fecero scavare un bacino artificiale vicino alla riva del Tevere (nella zona di Trastevere nei pressi della Chiesa di San Cosimato a Roma) lungo circa 550 metri e largo 360; un acquedotto costruito per portare l’acqua dal lago di Martignano (vicino al lago di Bracciano) lungo 33 Km capace di scaricare 180 litri di acqua al secondo per un ammontare di circa 200.000 metri cubi utili per riempire in 15 giorni la naumachia; un canale di collegamento tra il Tevere e la naumachia per permettere l’accesso delle navi impegnate nella battaglia; 30 navi rostrate biremi e trireme; 3.000 raffiguranti più i rematori ed un imponente servizio di guardia in ogni laddove per evitare che i ladri approfittassero dell’assenza dei romani per compiere saccheggi.
Tutto questo nel 2 a.C. per celebrare la festa per l’inaugurazione del Tempio di Marte Ultore e simulare la battaglia di Salamina tra persiani ed ateniesi.
Lo spettacolo aveva stravolto il senso delle proporzioni ma il popolo non piangeva le vittime ne tanto meno criticava l’incredibile costo della naumachia. I romani erano entusiasti di Augusto nonostante avesse sperperato più denaro del suo padre adottivo: Cesare.
Oltre alle naumachie citate si ricordano nel Campo Marzio la naumachia di Caligola e Domiziano e nelle vicinanze del mausoleo di Adriano la naumachia vaticana e quella fatta tenere da Filippo l’Arabo per le feste commemorative del millenario di Roma (questa sembra sia stata l’ultima naumachia eseguita). Nerone fece riempire con acqua di mare un anfiteatro in legno immettendo anche pesci e animali marini. Dopo la rappresentazione della naumachia venne fatta defluire l’acqua e nell’arena ormai asciutta si fronteggiarono gruppi di gladiatori.
Anche Tito volle ulteriormente perfezionare l’arte della naumachia in occasione dell’inaugurazione del Colosseo e ne fece allestire due: la prima dentro il Colosseo stesso con cavalli, tori e altri animali equipaggiati sia per il movimento nell’acqua che sulla terra per ricordare la battaglia tra Corfù e Corinto; nella seconda, sul lago artificiale di Augusto, per ricordare la vittoria degli ateniesi sui siracusani venne allestita una piccola isola dove i naumacharii vi sbarcarono e successivamente la espugnarono. Particolarmente famosa è rimasta la naumachia fatta organizzare da Claudio nel 53 d.C. sul lago Fucino per celebrare il termine dei lavori della costruzione dell’emissario del Liri fatto costruire per la grande bonifica del luogo. Sebbene lontano oltre 100 Km da Roma l’evento richiamò un foltissimo pubblico dalle città vicine e da tutta la capitale. Sul lago Fucino era stata organizzata la più maestosa delle battaglie navali mai organizzata tra la flotta rodiese e la flotta siciliana. Si affrontavano su 100 navi 19.000 guerrieri, probabilmente criminali, che come racconta Tacito “combatterono con un coraggio degno di soldati valorosi non risparmiando né se stessi né gli avversari”, mentre sulle rive erano appostati i pretoriani pronti ad intervenire contro quei combattenti che si mostravano incerti o riottosi. Un tritone d’argento appariva in mezzo al lago al momento opportuno per dare con la tromba il segnale della battaglia.
Particolarmente famosa è rimasta la naumachia fatta organizzare da Claudio nel 53 d.C. sul lago Fucino per celebrare il termine dei lavori della costruzione dell’emissario del Liri fatto costruire per la grande bonifica del luogo. Sebbene lontano oltre 100 Km da Roma l’evento richiamò un foltissimo pubblico dalle città vicine e da tutta la capitale. Sul lago Fucino era stata organizzata la più maestosa delle battaglie navali mai organizzata tra la flotta rodiese e la flotta siciliana. Si affrontavano su 100 navi 19.000 guerrieri, probabilmente criminali, che come racconta Tacito “combatterono con un coraggio degno di soldati valorosi non risparmiando né se stessi né gli avversari”, mentre sulle rive erano appostati i pretoriani pronti ad intervenire contro quei combattenti che si mostravano incerti o riottosi. Un tritone d’argento appariva in mezzo al lago al momento opportuno per dare con la tromba il segnale della battaglia.
Queste battaglie dovevano costare ingenti somme sia per l’organizzazione della battaglia stessa, sia per l’allestimento dello specchio d’acqua in cui si dovevano svolgere questi combattimenti. Per le enormi spese, per difficoltà tecniche e per motivi igienici a causa dei miasmi provocati dalle acque stagnanti, le naumachie non venivano rappresentate frequentemente come le altre forme di spettacolo ma soltanto per celebrazioni eccezionali. In seguito le naumachie non vennero quasi più organizzate forse perché era diventato impossibile competere con la maestosità di quelle precedenti ma, molto più probabilmente, a causa delle voragini aperte da queste stravaganti rappresentazioni nelle casse statali e nelle casse private di ricchi e imperatori. -
L’ammutinamento del cacciatorpediniere greco Velos
-
8.10.1859, affonda la cannoniera Sesia
di Guglielmo Evangelista (*)
foto internet…il primo mistero italiano.
L’Italia è un paese di misteri.
E’ vero che tutto il mondo è già di per sé un mistero anche senza ricorrere a meditazioni trascendentali, e diceva Shakespeare:
– “Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia, ma i misteri dell’Italia, come la cronaca ci insegna, sono particolari: conta poco il fatto mentre conta molto quello che succede dopo: c’è il desiderio di scoprire a tutti i costi un responsabile, di “abbellire” i fatti con particolari inventati ad hoc e, naturalmente, una sequela di polemiche sterili o interessate…” Il primo mistero dell’Italia unita fu quello della cannoniera Sesia.
Il primo mistero dell’Italia unita fu quello della cannoniera Sesia.
Correva l’anno 1859, e si combatteva la seconda guerra di indipendenza contro l’Austria condotta dal Piemonte con l’aiuto della Francia.
Dato che il lago di Garda e le terre vicine divennero il punto cruciale degli scontri fra i tre eserciti, si pensò di armare una flottiglia di piccole navi per pattugliare le coste lacuali e fronteggiare la Gardaseeflotille austriaca, piuttosto consistente e costituita da due grossi piroscafi-avviso, una dozzina di cannoniere e varie barche armate.
Per questo compito i cantieri francesi di La Seyne-sur-mer presso Tolone costruirono una serie di dieci cannoniere, cinque delle quali, smontate in sezioni, vennero subito inviate a Genova da dove furono avviate per ferrovia verso il Veneto. Fu un viaggio che presentò non poche difficoltà a causa delle gallerie appenniniche e dell’interruzione dei ponti sul Ticino e sul Chiese e fu anche necessario costruire un binario provvisorio dalla stazione di Desenzano al lago.
Si trattava di piccole navi, lunghe poco meno di 25 metri e dal dislocamento di 101 tonnellate armate con un unico cannone da 160 mm. La macchina aveva una potenza di soli 16 cavalli che permetteva una velocità di 7 nodi.
La loro abitabilità era risibile: la timoneria era priva di qualsiasi riparo e, a parte la sala macchine e la polveriera, c’’era un solo locale sottocoperta, giusto un ricovero per il personale libero dal servizio in caso di maltempo. Ovviamente l’equipaggio dormiva e mangiava a terra.
Insomma, non erano navi da combattimento, ma con la loro arma potevano battere efficacemente obiettivi costieri, tornando subito dopo alla base.
Erano però unità tecnicamente moderne: il cannone era rigato e a retrocarica e lo scafo aveva una robusta struttura mista legno-ferro.
Queste navi non fecero a tempo a partecipare al conflitto perché erano ancora in fase di rimontaggio al sopraggiungere dell’armistizio, ma rimasero sul lago al comando del capitano di fregata Giuseppe di Montezemolo e furono utilizzate in compiti di sorveglianza con base a Sirmione, proprio sul confine dato che il trattato di Villafranca aveva lasciato all’Austria il Veneto con l’arsenale di Pesciera e quindi metà del Garda era ancora in mano al nemico di sempre.
Le cinque navi, cedute dalla Francia al Piemonte, furono battezzate Frassineto, Torrione, Pozzolengo, Castenedolo e Sesia in ricordo di piccoli fatti d’arme della guerra appena conclusa.
Ora una piccola digressione: ogni italiano sa come alcuni anni dopo, nel 1866, le prendemmo sonoramente a Custoza e a Lissa. Beh, non fummo da meno anche sul Garda dove la nostra flottiglia di cannoniere fece una miserrima figura…le prendemmo anche lì.
Comunque torniamo al 1859, precisamente al 19 giugno.
Quel giorno l‘artiglieria piemontese aveva affondato il piroscafo Benaco, requisito e militarizzato dagli austriaci come trasporto munizioni. E’ da qui che comincia la nostra storia.
In dipendenza da quanto appena detto, una volta venuta la pace, non esistevano più sul Garda navi passeggeri e nessuna azienda si fece avanti per ottenere la concessione del servizio di linea.
Le rive gardesane sono aspre. Poche mulattiere conducevano per l’interno verso Brescia e da sempre la popolazione era abituata a spostarsi più comodamente via acqua.
Che fare?
Intervenne la Marina Piemontese (il Regno d’Italia sarebbe stato proclamato solo un anno e mezzo dopo) che decise di mettere a disposizione ogni 15 giorni, a turno, una delle sue cannoniere per effettuare servizio passeggeri lungo la costa occidentale da Salò fino a Limone.La bellezza del lago lo rendeva già allora mèta degli escursionisti, e in quel periodo c’erano molti veneti che, piuttosto che fermarsi sulla non meno attraente riva orientale, preferivano varcare il confine e godersi l’Italia.
L’8 ottobre 1860 alcune famiglie di aristocratici e di professionisti veronesi, che si trovavano in Lombardia in visita per qualche giorno ad alcuni amici, avevano deciso di fare una gita sul lago.
Erano quasi tutte persone con un passato patriottico, molte erano note alla polizia austriaca e in realtà la gita prevista non era turistica, ma costoro volevano avere la possibilità di protestare liberamente, sensibilizzando gli italiani, contro la fucilazione del soldato Luigi Lenotti avvenuta a Verona il 29 settembre precedente.
Bisogna dire, per amor di verità, che il Lenotti era stato giustiziato in quanto aveva tentato la diserzione e come tale – non perché italiano – era stato regolarmente processato secondo le durissime norme militari austriache.
Naturalmente i piemontesi stavano facendo la stessa cosa nell’Italia meridionale con i disertori e i renitenti alla leva ma, si sa, quando si tratta di ideologie si ragiona a senso unico….
Davanti alla sponda occidentale gardesana si trova l’isola di Lechi, ben conosciuta dagli equipaggi delle cannoniere perché vi si stavano facendo dei lavori di fortificazione e in quei giorni vi trasportavano personale e materiali del Genio militare.
Come d’abitudine, quando queste navicelle erano di turno, il Sesia pernottò all’isola in modo da poter essere più vicino a Salò per iniziare il suo servizio di linea, ma la mattina successiva si recò direttamente a Fasano, presso Gardone, dove imbarcò la comitiva patriottica; saltò quindi tanto lo scalo di Salò quanto quelli successivi di Maderno e Gargnano, proseguendo direttamente per Limone, dove sostò un’ora, imbarcò vari altri comuni passeggeri e a mezzogiorno preciso cominciò il viaggio di ritorno.
Un quarto d’ora dopo, percorse un paio di miglia e a poche centinaia di metri dalla riva, di fronte alla località Bine, i contadini al lavoro sui campi a terrazze della zona udirono un boato e fecero in tempo a vedere il ponte della cannoniera che si sollevava in aria per alcuni metri mentre il fasciame sottostante si disintegrava. Quello che restava fu trascinato rapidamente sott’acqua dal peso del grosso cannone che costituiva l’armamento della nave.
Un marinaio, con prontezza di spirito, riuscì a tranciare il cavo della scialuppa che la cannoniera si portava a rimorchio e che fu raggiunta a nuoto da alcuni membri dell’equipaggio che poi riuscirono a recuperare qualche naufrago. Va notato che le fonti sono spesso discordanti: si salvò Giacomo Giorgi che, in quanto al timone, fu scambiato per il comandante Raggio, mentre quest’ultimo, un ligure appartenente al corpo dei Piloti, vi perse la vita assieme al sottufficiale macchinista Giacomo Portigliati.
Come sempre quando avvengono esplosioni di questo tipo i fortunati furono coloro che erano stati catapultati fuori bordo dalla spostamento d’aria, ma ben pochi sapevano nuotare e i così, fra annegati, morti nell’esplosione e altri trascinati sul fondo dal risucchio provocato dal relitto, le vittime furono 42: 33 passeggeri e 9 marinai.
Il rumore fu sentito e il fumo fu visto dalla sponda opposta dove il comandante del presidio della marina austriaca di Malcesine, Giorgio Shellek, fece uscire subito una lancia che riuscì a salvare cinque naufraghi che si aggiunsero ai 13 che erano riusciti a raggiungere la scialuppa.
Dopo il disastro furono promessi premi a chi riuscisse a recuperare i corpi, scatenando l’accorrere di pescatori e barcaioli che nonostante la profondità ottennero qualche successo: furono 22 i morti recuperati, che vennero in gran parte sepolti nel cimitero di Limone.La versione ufficiale sulla causa del disastro fu lo scoppio della caldaia, ma appare strano che questa, di potenza ridicolmente esigua, avesse potuto causare un disastro così grave ad una nave da 100 tonnellate, in parte in ferro e praticamente nuova.
Così si parlò di un attentato austriaco inteso a colpire le famiglie patriottiche veronesi che erano a bordo, cosa che secondo alcuni sarebbe stata confermata dalla troppa sollecitudine dei soccorsi provenienti dall’altra sponda dove una barca sarebbe stata già pronta per salpare immediatamente: il comandate austriaco era stato informato che doveva succedere qualcosa?
Un’ altra stranezza riguarda il fatto che il comandante abbia deciso di cambiare orari e itinerari per compiacere dei viaggiatori, certo importanti, ma legalmente degli stranieri e questo su di una nave in servizio di linea e per di più militare. Raccomandazioni, connivenze o ordini dall’alto?
Nel 2011 il Sesia è stato ritrovato da ricercatori subacquei alla profondità di ben 334 metri e qui viene suggerito un ultimo mistero: nella discesa la nave non si è capovolta, segno che i pesi principali, cannone e macchina, erano rimasti al loro posto assicurando stabilità al relitto, ma se la caldaia fosse scoppiata si sarebbe frammentata alterando gli equilibri.
Inutile dire che tutti questi interrogativi sono – e forse lo saranno sempre – ancora senza risposta.
(*) Per saperne di più sull’autore digita, sul motore di ricerca del blog, il suo nome e cognome.
-
Le superstizioni dei marinai
di Antonio Cimmino e Pancrazio “Ezio” Vinciguerra


Le superstizioni dei marinai
di Pancrazio “Ezio” Vinciguerra …a Donato e Claudio per il prezioso suggerimento e per la profonda stima e amicizia.
…a Donato e Claudio per il prezioso suggerimento e per la profonda stima e amicizia.Ma i marinai sono superstiziosi? Proverbialmente sembra proprio di si e per menzionare tutte le loro superstizioni bisognerebbe scrivere un’enciclopedia. La storia della marineria è intrisa di riti scaramantici ancora oggi diffusi.
Stregonerie, esorcismi, rituali pagani e religiosi erano e sono il pane quotidiano di capitani e marinai sempre attenti a non sfidare le regole della fortuna e ingraziarsi, con riti propiziatori, la benevolenza degli elementi naturali. Di natura irrazionale, le superstizioni possono influire sul pensiero e sulla condotta di vita delle persone che le fanno proprie. Il credere che gli eventi futuri siano influenzati da particolari comportamenti, senza che vi sia una relazione casuale, vengono da molto lontano. La paura dell’ignoto e dell’immensità degli oceani ha generato sin dagli albori della navigazione una fitta serie di credenze. Per secoli miti e leggende sono stati tramandati a colmare col soprannaturale, quel vuoto che la razionalità ancora non riusciva a riempire. In Grecia, per esempio, si compivano sacrifici umani per assicurarsi il favore degli dei. Così Agamennone, re di Argo, fece immolare sua figlia Ifigenia per ottenere nuovi venti per le navi che dovevano lasciare Troia. I vichinghi invece versavano il sangue degli schiavi sgozzati in segno di benedizione prima del varo di una nave o prima di intraprendere la navigazione. I miti e le leggende che si narravano intorno al mare e alle terribili creature che lo abitavano assunsero tinte ancora più fosche con il diffondersi del cristianesimo, quando a fare degli oceani campi di battaglia, non furono più dei capricciosi spiriti malvagi, ma santi e satanassi. Alle tempeste opera del diavolo venivano contrapposti ed invocati i santi (tutt’ora i marinai invocano per esempio Santa Barbara durante i forti temporali). Sempre durante il cristianesimo non si potevano mollare gli ormeggi il primo lunedì del mese di aprile perché coincideva con il giorno in cui Caino uccise Abele oppure il secondo lunedì di agosto era meglio restare in porto: in quel giorno Sodoma e Gomorra furono distrutte; partire poi il 31 dicembre era altrettanto di cattivo auspicio perché era il giorno in cui Giuda Iscariota si impiccò.
 Gli agenti atmosferici come i “fuochi di Sant’Elmo” o come il passaggio di una cometa erano presagi buoni o cattivi a seconda dell’interpretazione che se ne dava; mentre una tromba d’aria in avvicinamento all’orizzonte poteva essere “tagliata” con una spada e deviata recitando una preghiera o una formula magica; le onde si placavano mettendo in mostra i seni nudi di una polena, o facendo scoccare in acqua dal più giovane dei marinai una freccia magica.
Gli agenti atmosferici come i “fuochi di Sant’Elmo” o come il passaggio di una cometa erano presagi buoni o cattivi a seconda dell’interpretazione che se ne dava; mentre una tromba d’aria in avvicinamento all’orizzonte poteva essere “tagliata” con una spada e deviata recitando una preghiera o una formula magica; le onde si placavano mettendo in mostra i seni nudi di una polena, o facendo scoccare in acqua dal più giovane dei marinai una freccia magica.Anche gli animali non erano (…sono) immuni dai preconcetti scaramantici. Il gatto, malgrado ami poco il contatto dell’acqua, ha trovato un posto di tutto rispetto sui vascelli. La ragione della sua presenza a bordo si collega alla sua naturale propensione a scovare i roditori ed era anche ritenuto capace di prevedere eventi climatici: se soffiava significava che stava per piovere, se stava sdraiato sulla schiena c’era da aspettarsi una bonaccia, se era allegro e baldanzoso il vento stava per arrivare; se un gatto inoltre andava incontro un marinaio sul molo era segno di buona fortuna, se gli tagliava la strada il contrario (oggi per alcuni se un gatto nero ti attraversa la strada è presagio di brutte notizie); se si fermava a metà strada c’era da aspettarsi invece qualcosa di sgradevole. Si riteneva infine che i gatti potessero invocare una tempesta grazie al potere magico delle loro unghie. Per questa ragione a bordo si faceva sempre in modo che fossero ben nutriti e coccolati. Tra gli uccelli gabbiani e albatros erano l’incarnazione dei marinai morti in mare e portatori di tempeste. Peggio ancora se un cormorano si posava sul ponte di una nave e scuoteva le ali, guai a fargli del male si era posato per rubare l’anima di qualcuno e avrebbe significato naufragio sicuro. Così se tre uccelli si trovavano a volare sopra la nave in direzione della prua, l’equipaggio si disperava per l’imminente disgrazia da questi annunciata. Se uno squalo per esempio seguiva la scia di una nave era di cattivo auspicio perché si credeva fosse in grado di fiutare l’odore della morte. Diversamente i delfini e le rondini erano di buon augurio.
Ma le superstizioni colpiscono anche le persone e allora: “occhio, malocchio prezzemolo e finocchio” (come avrebbe recitato il principe De Curtis).
Gli avvocati (categoria particolarmente detestata dai marinai inglesi che li apostrofano spregevolmente squali di terra) e i preti (averli a bordo rappresentava una aperta sfida a Satana) portavano male (…avvocati, preti e polli non sono mai satolli). Stessa sorte per la donna averla in barca portava male (ora non si dice più, forse per la parità dei sessi). Secondo alcune tradizioni però una donna nuda, o incinta poteva placare anche la più terribile delle tempeste. Poi non ci poteva essere cosa peggiore, prima di salpare, di incontrare una persona con i capelli rossi, con gli occhi storti o con i piedi piatti (…rosso malpelo sprizza veleno). L’unica modo per salvarsi in questo caso era parlargli per prima.
 C’erano e ci sono usanze che i marinai cercano assolutamente di evitare a bordo: indossare abiti di un altro marinaio, soprattutto se morto nel corso dello stesso viaggio; evitare di fare cadere fuori bordo un bugliolo o una scopa; imbarcare un ombrello, bagagli di colore nero, fiori e guardare alle proprie spalle quando si salpa); salire a bordo della nave con il piede sinistro; poggiare una bandiera sui pioli di una scala o ricucirla sul cassero di poppa (attualmente i marinai italiani nel ripiegare la bandiera lasciano il colore verde fuori in segno di speranza); lasciare le scarpe con la suola verso l’alto (presagio di nave capovolta); accendere una sigaretta da una candela (significava condannare un marinaio a morte); evitare il suono prodotto dallo sfregamento del bordo di un bicchiere o di una tazza; il rintocco della campana di bordo se non mossa dal rollio; pronunciare le parole: verde, maiale, uovo, tredici, coniglio; parlare di una nave affondata o di qualcuno morto annegato; indossare le magliette fornite dall’organizzazione di una regata; capi di abbigliamento nuovi; cambiare nome a una barca o battezzarla con un nome che finisce con la lettera “a”(in passato è stata sempre una eresia, soprattutto in Italia è ancora fonte di numerosi scrupoli. I francesi hanno risolto il problema cambiando il nome a ferragosto e mettendo in atto questo rituale: procedendo di bolina la barca deve compiere sei brevi virate e poi scendere in poppa piena tagliando in questo modo la sua stessa scia. In questo modo, secondo alcuni, si disegnerebbe un serpente che si morde la coda scongiurando la iella. Solo a questo punto la barca sarà pronta a un nuovo nome ) e tantissime altre superstizioni.
C’erano e ci sono usanze che i marinai cercano assolutamente di evitare a bordo: indossare abiti di un altro marinaio, soprattutto se morto nel corso dello stesso viaggio; evitare di fare cadere fuori bordo un bugliolo o una scopa; imbarcare un ombrello, bagagli di colore nero, fiori e guardare alle proprie spalle quando si salpa); salire a bordo della nave con il piede sinistro; poggiare una bandiera sui pioli di una scala o ricucirla sul cassero di poppa (attualmente i marinai italiani nel ripiegare la bandiera lasciano il colore verde fuori in segno di speranza); lasciare le scarpe con la suola verso l’alto (presagio di nave capovolta); accendere una sigaretta da una candela (significava condannare un marinaio a morte); evitare il suono prodotto dallo sfregamento del bordo di un bicchiere o di una tazza; il rintocco della campana di bordo se non mossa dal rollio; pronunciare le parole: verde, maiale, uovo, tredici, coniglio; parlare di una nave affondata o di qualcuno morto annegato; indossare le magliette fornite dall’organizzazione di una regata; capi di abbigliamento nuovi; cambiare nome a una barca o battezzarla con un nome che finisce con la lettera “a”(in passato è stata sempre una eresia, soprattutto in Italia è ancora fonte di numerosi scrupoli. I francesi hanno risolto il problema cambiando il nome a ferragosto e mettendo in atto questo rituale: procedendo di bolina la barca deve compiere sei brevi virate e poi scendere in poppa piena tagliando in questo modo la sua stessa scia. In questo modo, secondo alcuni, si disegnerebbe un serpente che si morde la coda scongiurando la iella. Solo a questo punto la barca sarà pronta a un nuovo nome ) e tantissime altre superstizioni.E’ invece di buon augurio per un marinaio avere un tatuaggio; lanciare un paio di scarpe fuori bordo immediatamente dopo il varo di una nave, indossare un orecchino d’oro (usanza antica che serviva a coprire le spese di sepoltura qualora il marinaio fosse deceduto); toccare il solino o la schiena di un marinaio; dipingere occhi sul moscone delle barche.
 Oggi quando si vara una nave ci si limita a versare dello champagne sul ponte. Più raramente si lancia contro lo scafo l’intera bottiglia del prezioso vino: se questa si rompe è di buona sorte, altrimenti sono dolori.
Oggi quando si vara una nave ci si limita a versare dello champagne sul ponte. Più raramente si lancia contro lo scafo l’intera bottiglia del prezioso vino: se questa si rompe è di buona sorte, altrimenti sono dolori.Il pallino della superstizione di chi va per mare non accenna a svanire neppure oggi e, se non è superstizione, è certamente scaramanzia. E’ bene ricordare a tutti che qualunque marinaio prima di salpare, come nella vita di tutti i giorni, non accetta di buon grado gli “auguri” o i “buona fortuna”. Meglio porgergli in “bocca al lupo” o “in culo alla balena”.
-
4.10.1917, la vera storia del piroscafo Città di Bari
Segnalato da Nico Vernì

Prof. Giovanni Vernì – LA VERA STORIA
del triste epilogo del piroscafo “Città di Bari”, silurato dal SMG tedesco UB48.PORTO DI TARANTO – MAR PICCOLO, Giovedì 4 ottobre 1917.
Aria serena. Giornata mite e piena di sole, che fa ben sperare; una bella giornata ottobrina.
Il solito movimento del tempo di guerra, piuttosto ordinato e circospetto; il solito andirivieni tra le banchine del gran porto tarantino.
Navi alla fonda, navi che vanno, navi che vengono; mercantili o da guerra. Ultimi controlli per i passeggeri pronti all’imbarco.
Attorno ad una, in particolare, ferve sin dal mattino un’insolita attività: si stanno mettendo a punto le ultime cose: fra le quali il funzionamento di un cannoncino da 76 m/m, di cui essa è stata dotata da poco; si stanno caricando le poche mercanzie, imbarcando, alla spicciolata, senza fretta alcuna, i pochi passeggeri, tutti militari, per la vicina Macedonia, via Grecia.
E’ il piroscafo “Città di Bari”.
Lo comanda un giovane ma esperto lupo di mare, un barese doc, credo, probabilmente parente stretto del defunto Pantaleo Castellano, un coraggioso di poche parole, concreto, essenziale, il capitano L.Castellano, coadiuvato da un eccellente equipaggio, composto, in gran parte, di pugliesi, se non di baresi – i Violante, p.e., i De Santis, i De Tullio, i Cassano, gli Introna, i Bottalico, i Bellomo, per dirne qualcuno. Chi ne volesse conoscere tutti i nomi, uno per uno, può scorrerne gli elenchi che noi alleghiamo in questo volume, sez. Documenti.
Prima dello scoppio della “Grande Guerra” il “Città di Bari” aveva solcato con dignità e onore l’Adriatico e lo Jonio, soprattutto, attivamente partecipando ai traffici commerciali che si svolgevano nei due mari e tenendo ben collegate tra di loro le sponde che ne erano bagnate.
Con l’entrata in guerra del nostro Paese, era stato requisito e, armato di cannone, dopo aver partecipato alle operazioni di salvataggio, da parte della Regia marina, dell’esercito Serbo-Montenegrino e di trasporto, da S.Giovanni di Medua a Brindisi, dei membri del governo slavo e del tesoro statale (come provano e documentano fonti italiane e britanniche pubblicate dalla Rivista Marittima del gennaio 2003, che qui di seguito vi mostriamo), veniva adibito ad “ausiliario” della Regia Marina Militare, nel servizio-postale e passeggeri, con partenza da Taranto, al giovedì, sulla linea Taranto – Gallipoli – Corfù – Patrasso.
E qui, proprio qui, su questo tratto, la malasorte volle che, nel viaggio che stiamo per raccontare, si compisse il suo tragico destino.IL FATTO
La partenza del “Città di Bari” da Taranto. L’arrivo e la sosta a Gallipoli. L’imbarco di civili greci. Il primo siluramento. Il secondo siluramento. L’ammutinamento dei greci. Il cannoneggiamento da parte del sommergibile siluratore. L’affondamento del piroscafo. La scomparsa del capitano comandante. Lo sbandamento dei naufraghi.
Lasciata Taranto nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre, il “Città di Bari” giunse a Gallipoli (l’antica KalhpoliV, o “Città Bella”, fiorente centro commerciale affacciato sullo Jonio, a 38,5 Km. da Lecce), nelle prime ore della sera dello stesso giorno.
Era solo, senza scorta, avendo a bordo, oltre all’equipaggio civile composto di 40 persone e all’equipaggio militare di 11, soltanto 37 (o 35?) passeggeri militari del Regio Esercito (c’era tra questi il padre di chi scrive, Pasquale, soldato del “271° Btg. Milizia Territoriale”, dislocato sul fronte Macedone, al quale faceva ritorno dalla licenza) e della Regia Marina ed un carico di 130 tonn. di viveri e materiali vari .
“Quando il “Città di Bari” giunse a Gallipoli – narra nel suo interrogatorio l’Ufficiale di Porto – mi recai a bordo della nave, e il Capitano di questa, Luigi Castellano, mi chiese se il Piroscafo “Imera”, silurato due giorni prima, avesse avuto la scorta. Alla mia risposta negativa disse: “Chissà se per noi vi sarà la scorta”. Risposi che non sapevo, ma che però non lo credevo e, quindi, lo informai che i passeggeri da imbarcare superavano le cento unità.
Al mattino seguente informai il Comandante di Spiaggia delle parole scambiate col Capitano a riguardo della scorta. Il Comandante Stranges mi rispose di non avere facoltà di dare la scorta, ma che, se il Capitano l’avesse ufficialmente richiesta, avrebbe telegrafato a Taranto per l’autorizzazione. Mi recai nuovamente a bordo e riferii quanto sopra al Capitano, ma questi mi rispose che non voleva chiedere scorta per non far credere di avere paura. Se queste non furono le sue precise parole, certo il senso ne era equivalente.
Rimasi a bordo del Piroscafo tutto il pomeriggio e verificai se tutti avessero il salvagente e se lance e zattere fossero a posto, libere da impedimenti ed in numero sufficiente, del che ebbi anche assicurazione dal Capitano.
Non mi occupai, perché non di mia competenza, del ritiro delle armi dei passeggeri; per quanto mi consta, ciò non fu fatto né dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, né da quella di bordo, né dagli Agenti della Regia Dogana.
Ritornai a terra mezz’ora prima della partenza e riferii al Comandante di Spiaggia che il Capitano non aveva creduto di chiedere la scorta.
Il “Città di Bari” partì regolarmente alle 18h,30m. A tenore delle norme vigenti, non feci alcun telegramma di partenza, però, in vista del rilevante numero di passeggeri, telegrafai subito ai Servizi Logistici che il Piroscafo era partito con 400 passeggeri”.
“Imbarcati, dunque, 405 passeggeri e come merci del vino e dei tessuti di cotone – scrive il Contrammiraglio Paladini – il Piroscafo lasciava, alle ore 18.30 del 5 ottobre, il porto di Gallipoli……La partenza del Piroscafo fu telegrafata al Ministero, al Dipartimento di Taranto ed al Comando in Capo dell’Armata di Taranto, con queste parole: “Piroscafo «Città di Bari» mare” – Nessun telegramma fu fatto invece ai Comandi Navali di Brindisi, Valona e Corfù”, perché, – si giustifica lo Stranges nel suo interrogatorio – nessun ordine di tale specie avevo per quanto riguarda la partenza per Corfù”. E nessuna scorta fu data al Piroscafo, perché, – sempre a dire dello Stranges – non avevo alcuna istruzione di fornire scorta per interi viaggi, perché il Città di Bari è partito dopo il tramonto, ma, soprattutto, perché il Capitano del Piroscafo si diceva riluttante a dar mostra di temere il pericolo”.
Trascorsero tranquille – scrive sempre il Paladini – le prime ore della notte”: notte di luna – ricordano i superstiti -; aria fosca; forte vento di E-NE che rendeva il mare agitato; visibilità scarsa.
Ma, attorno alla mezzanotte, tra le 23h,45m e le 24h, il marinaio Albano – che era di guardia al cannone, e qualche altro, videro passare di poppa la scia di un siluro. Avvisato, il Capitano della nave, si portò immediatamente sul posto, ma, non trovando conferma del lancio prospettatogli e non scorgendo alcun segno della presenza del sommergibile siluratore – (probabilmente perché questo si é affrettato a far perdere traccia di sé) – credette ad un abbaglio e tutto finì lì.
Invece abbaglio non era e l’Albano e gli altri avevano visto giusto.
E la conferma ce la dà il sopravvissuto – italiano o straniero? membro dell’equipaggio del «Città di Bari» o anonimo passeggero? – fatto prigioniero e condotto poi a Pola, del quale, però, la fonte austriaca non rivela il nome per ragioni di riservatezza .
Alle Autorità di marina che lo interrogavano, il sopravvissuto anonimo raccontò che quel primo lancio il sommergibile siluratore lo effettuò esattamente alle 2h,30m del mattino del 6 ottobre. (“Am 6 Oktober um 2 Uhr 30′ a.m.”, è scritto nel documento precitato) e che il “Città di Bari” rispose all’attacco sparando alcuni colpi di cannone – (“Antwortete mit seinen Kanonen”).
Veri o falsi, in tutto o in parte, questi particolari, sta di fatto che un primo siluro fu effettivamente lanciato contro il piroscafo italiano e che, probabilmente, l’U boot tedesco, andato a vuoto quel suo primo tentativo di siluramento, temendo la reazione del “Città di Bari”, sospese momentaneamente l’attacco per riprenderlo più tardi.
L’allarme, perciò, rientrò; la calma ritornò a bordo e tutti tirarono un sospiro di sollievo.“L’aria era fosca ed un forte vento di E, NE rendeva il mare agitato. Le 4 erano passate da circa un quarto d’ora – racconta il 2° Ufficiale del Piroscafo – e mi trovavo in sala nautica allorché udii lo scoppio…
“Il tempo era quasi nuvoloso, tirava un vento moderato da scirocco ed il mare era mosso. Si diceva anche che era possibile qualche sorpresa all’alba. Alle 4h,10m circa, udimmo una forte esplosione”…- ricorda il 1° Ufficiale .
“Mi trovavo sul primo cassero, – narra a sua volta il direttore di macchina – passeggiavo tra l’osterigio di macchina e la sala nautica; erano passate da poco le 4h,00m allorché udii un colpo metallico fortissimo e vidi sollevarsi dall’osterigio di macchina un’alta colonna di acqua e vapore. Il siluro aveva colpito il bastimento proprio fra la caldaia e le macchine, che si fermarono immediatamente, insieme naturalmente alle due dinamo. Il bastimento rimase all’oscuro”.
“Svegliato dall’esplosione, – racconta, tra l’altro, Luigi Aleotti per prima cosa corsi abbasso nella stazione R.T. che si trovava proprio nel corridoio che univa la prima con la seconda classe: vidi tutti gli strumenti per terra e capii che la stazione non poteva più funzionare. In coperta la gente si agglomerava intorno alle sei imbarcazioni. Vi erano anche molte zattere, circa 16 in legno e sei od otto in ferro.
Il Comandante era sulla dritta e il capo timoniere sulla sinistra; ambedue cercavano di ottenere un po’ di calma, per effettuare ordinatamente il salvataggio, ma questo non fu possibile, data la resistenza armata dei Greci: gettavano gli zatteroni a mare senza ritenuta, facevano capovolgere le lance, venivano alle mani…”
“Intanto il bastimento si sbandò un poco a dritta, molto a sinistra, e quindi si immerse per circa due metri, rimanendo orizzontale. Una ventina di minuti dopo il siluramento – ricorda ancora il 2° Ufficiale -, arrivò la prima granata che cadde una ventina di metri a sinistra del bastimento. La seconda, credo colpisse il cannone di poppa. Seguirono altri colpi. Appena cominciato il fuoco, non fu possibile impedire alla gente di gettarsi a mare raggiungendo le zattere che, filate e senza ritenute, s’allontanavano dal bordo.”
“Svegliato dall’esplosione, – riferisce a sua volta il sottocapo cannoniere – corsi subito vicino al pezzo, ma non vidi nulla. Dopo un po’ scesi dalla tuga per cercare il capo timoniere ed il Comandante. Trovato il capo timoniere, andai con lui ad aiutare a mettere le zattere in mare.
Mentre facevo questa operazione, ho udito il primo colpo di cannone e visto il sommergibile al traverso a sinistra. Corsi subito a poppa, ma fui fermato dai Greci che non volevano si sparasse, temendo che il sommergibile, per rappresaglia, sparasse sulla gente a mare…
…Prima di buttarmi a mare – a bordo eravamo rimasti solo io e il sottocapo francese AUGER Renè – vidi i Greci che facevano segno al sottomarino con una camicia, affinché non sparasse più. Mi precipitai addosso e strappai loro la camicia…
All’ultimo momento i Greci ammainarono pure la bandiera italiana”.
“Restai a bordo fin quasi all’ultimo – ricorda VALENZO Pietro. Vidi all’inizio del bombardamento che dei Greci facevano segnale al sommergibile gridando: “Costantino” .
“Dopo una mezz’ora – racconta il marinaio cannoniere FAVAZZA Salvatore – il sommergibile emerse a circa 200 metri dalla poppa e cominciò a bombardare. Due colpi raggiunsero il fumaiolo ed uno colpì in prossimità della stiva prodiera. Durante il bombardamento (a base di granate incendiarie) solo io rimasi in prossimità del cannone. Poco dopo, però, me ne andai per mettermi al riparo. Il sottomarino, allora, si affiancò a dieci o quindici metri di distanza e mi si domandò in buon italiano dov’era il Comandante. Gli risposi che non c’era…”
“Nel frattempo il sommergibile si era avvicinato al Piroscafo e aveva sbarcato il radiotelegrafista dell’IMERA su una zattera – riferisce il 2° Ufficiale-. Tirò una cannonata sulla prua del Piroscafo al galleggiamento determinando l’affondamento”.
Colpito a morte, senza preavviso, da quindici granate incendiarie, l’ultima delle quali al bagnasciuga, tutte sparate tranne l’ultima, mentre la gente era ancora a bordo e cercava in tutti i modi e con tutti i mezzi di convincere gli artiglieri di bordo a non sparare contro il sommergibile e, alzando bandiera bianca e ammainando la bandiera italiana, quelli del sommergibile a non sparare sui passeggeri ancora presenti sulla nave, il “CITTA’ DI BARI”, lentamente affondò in fiamme – “…endlich sank das schiff in flammen”.
Trascinando con sé, in fondo al mare, uomini e cose e inabissandosi a 39° 20′ Lat.N., 19° 23′ Long.E. – rotta 107° magnetico da un punto 15 miglia a sud di S.Maria di Leuca – al largo dell’isoletta di Paxòs o Paxì, a sud di Corfù, nel mentre in cielo e sul mare già albeggiava e si scatenava un furioso temporale che durò tutta la notte.
Sfasciate le imbarcazioni per l’imperizia dei Greci che se n’erano impadroniti e che pagarono con la vita l’atto precipitoso, le zattere di bordo raccolsero i rimanenti passeggeri e affrontarono il viaggio della salvezza, che per i più non giunse mai.
Ma, quasi a rendere più intricata e drammatica la fase finale di questa angosciosa vicenda, ecco, fosco ed oscuro, il dramma personale del coraggioso sfortunato Capitano: non é presente fisicamente, come noi ci aspetteremmo, alla morte della sua nave.
Eppure, subito dopo l’esplosione del secondo siluro, molti lo hanno visto, lo hanno notato, mentre…
…si precipitava fuori (della cabina di comando) gridando: “Salvagenti a posto”! – deposizione del secondo ufficiale -;
…cercava di organizzare il salvataggio e infondere un po’ di calma” -(direttore di macchina)-;
…sulla dritta cercava di ottenere un po’ di calma per effettuare ordinatamente il salvataggio…, ma questo non fu possibile, data la resistenza armata dei greci –
…diceva all’artigliere: “Sono Capitano e la mia nave è stata già silurata. Non faccia fuoco, altrimenti sparano contro le zattere!” – (primo timoniere) -;…
…vedendo la nave sbandare a dritta in modo che giudicò pericoloso, ordinava: “Gente in riga e zattere e lance a mare!” – (primo ufficiale) -;…
Dopo tutto questo, il Capitano non si vede più, esce di scena, scomparendo proprio mentre ci si aspettava di vederlo, nel solco della tradizione marinara, fermo al suo posto di comando, andare coraggiosamente a fondo e morire insieme con la sua nave.
Secondo un testimone oculare, egli si gettò a mare. Infatti, il primo cameriere testimoniò: “Mi gettai a mare dopo il Comandante dal boccaporto n.2″.
Allora, gettatosi a mare, è per caso affogato? o, piuttosto, è sembrato gettarsi a mare, mentre, invece, vi cadeva accidentalmente probabilmente ferito a morte da…”quel colpo di rivoltella sparatogli contro dal basso da uno sconosciuto?”, come racconta nella sua deposizione il 2° Capo timoniere?.
Non lo sapeva chi gli stava dattorno, non lo sappiamo nemmeno noi.
Se, però, dobbiamo dar credito alla fonte austriaca, il capitano Castellano sarebbe morto di morte violenta, ucciso, con altri, durante la sommossa scoppiata a bordo del piroscafo in seguito alle prime cannonate sparate dal sommergibile.
Vera o falsa, questa versione, verosimili o inventati questi particolari, il mistero resta e ci è difficile svelarlo.
Quando, verso le ore 5.30 del mattino, la luce del giorno scese a illuminare questa parte del Mar Jonio, sulla scena del disastro non c’era più nulla ormai: non la snella mole della bella nave barese, sprofondata con tutto il suo carico negli abissi; non la sagoma scura del sommergibile tedesco, apparentemente assente, ma, di fatto, aggirantesi ancora minaccioso in quei paraggi; non le scialuppe di salvataggio, che, pur stracariche di naufraghi, vagavano sempre più lontane, alla deriva, facile preda delle onde, delle correnti e della forza dei venti.“Nelle zattere si trovarono mescolati italiani e greci, che, numerosi, usarono soprusi e violenze, pestando coi piedi e ferendo di coltello e rasoio i nostri connazionali ed altri che si affollavano intorno alle già gremite imbarcazioni .”
Dura, lunga e faticosa fu la lotta dei naufraghi in una situazione oltremodo loro avversa, folle e vana la speranza di veder arrivare da un momento all’altro il soccorso liberatore: Corfù non sapeva; Taranto nemmeno. Finché, poi, qualcuno non darà l’allarme.
Nella notte, ad appena poche ore dall’affondamento, qualcuna delle zattere giunse anche a vedere in lontananza la terra della salvezza, …”ma il forte mare ci impedì assolutamente di avvicinarci a Fano, racconta un sopravvissuto.EPILOGO
I soccorsi. Il recupero e il ricovero dei naufraghi superstiti negli ospedali di Gallipoli e di Corfù. L’inchiesta. L’amaro bilancio. Considerazioni finali.
Nessun mezzo di soccorso videro i naufraghi durante tutto il giorno 6.
“Verso il mezzogiorno del 7 – appena due ore prima che fossero scoperti e tratti in salvo – calmatosi ormai il mare, abbiamo visto una leggera imbarcazione, una specie di caicco, contenente un greco. Un greco che era con noi allora abbandonò la nostra zattera e andò a parlare con quello. Ritornò poco dopo dicendo che quella imbarcazione non poteva salvarci ” .
“ Verso le prime ore del pomeriggio (del 7) apparve l’ESPERO ”.
“ Potevano essere le 2.00 del pomeriggio, allorché avvistammo un caccia ed un rimorchiatore”…credo che la nostra zattera sia stata l’ultima ad essere recuperata dall’ESPERO ”.
“ Alle 01.30 del giorno 7 – racconta il Comandante della Settima Squadriglia – ricevetti a Taranto un fonogramma che mi ordinava di accendere i fuochi per eseguire una missione.
Ricevetti solo verso le 3.00 le istruzioni scritte che dicevano:
di percorrere la rotta del Città di Bari che non era ancora giunto a Corfù. Dovevo continuare le ricerche fino al tramonto e passare la notte a Gallipoli.
Partii alle 3.30 da Taranto con una velocità di 20 miglia e seguii la rotta ordinatami… Avvistai la prima zattera verso le 2.05 / 2.10 del pomeriggio.
Questa conteneva tre o quattro uomini tra cui il 2° Ufficiale… Siccome sapevo che pure alla ricerca dei naufraghi si trovavano i C.T. “Pilo” e “Bronzetti”, feci loro un radiotelegramma, comunicandogli le coordinate geografiche del luogo ove mi trovavo. Infatti, dopo appena un quarto d’ora, essi arrivarono. Vennero altri due idrovolanti francesi che indicavano la posizione delle zattere. Continuai il salvataggio sino alle 16.45, raccogliendo ben 98 persone. Tra i salvati ve n’erano 97 della Città di Bari e uno R.T. dell’ “IMERA”. Avendo visto che vi erano dei feriti da coltello, ordinai il disarmo generale. Un greco, DEMETRE PRIFTIS, consegnò un rasoio insanguinato. A Gallipoli tutti i naufraghi ebbero assistenza.”
A loro volta, il “Pilo” e il “Bronzetti”, ne recuperarono altri 58 che provvidero a trasportare all’ospedale di Corfù.
“Di 493 persone che erano a bordo al momento della partenza da Gallipoli, – conclude malinconicamente nella sua relazione il Comandante della Divisione Base di Taranto – solo 156 si erano salvate e pure é certo che lo scoppio non può aver ucciso che, al massimo, una diecina di persone e che qualche altro può aver trovato la morte per aver battuto qualche forte colpo nel gettarsi in mare, forse tra questi ultimi il Capitano del piroscafo, del quale non si riuscì ad avere alcuna notizia dopo l’affondamento.”
Dunque, terminate le operazioni di ricerca e fatta la conta dei superstiti, all’appello risposero soltanto 156 persone – (160, secondo la fonte austriaca).
E le altre 337 o 368 o 560, o forse più? (se dobbiamo credere alla predetta fonte straniera).
Disperse. Morte. Tutte morte. Tutte finite in fondo al mare. Precipitatevi, non dalla nave che le trasportava, ma dalle scialuppe di salvataggio, in cui erano riuscite, bene o male, a trovar posto, prima che il “ Città di Bari ” affondasse. Precipitatevi da sole. Lasciatevisi andare così, con semplicità, quasi con un dolce senso di abbandono e di rassegnazione nel proprio destino. Uccise dagli stenti, dal maltempo, dalla violenza di prepotenti compagni di viaggio, dagli scoraggiamenti, dalla lunga attesa e permanenza in mare – durata, è incredibile, un giorno e mezzo! –
Ce ne parlano diffusamente, nelle loro deposizioni, i pochi fortunati superstiti. Basti leggere, come ha fatto l’orfano che scrive, – “ un groppo alla gola, l’occhio inumidito di pianto, il cuore in subbuglio ” – gli scioccanti racconti che i superstiti fanno alle autorità giudiziarie.
Vi trovi tutto:
La logica perversa della guerra;
L’imponderabilità;
L’imprevedibilità, l’inevitabilità, la fatalità, – come si usa dire in certi casi – degli eventi;
L’impotenza dell’uomo nella lotta contro le forze scatenate della natura;
L’insano egoismo, che spesso scaccia vincendolo l’altruismo, e sempre alberga nel cuore dell’uomo – come inorridisce tutta quella violenza! come suonano male tutti quei “mors tua, vita mea”, lanciati dal fratello contro l’altro fratello, al momento del pericolo!;
L’irresponsabilità, o la totale mancanza di senso di responsabilità, la superficialità, la leggerezza nel governare talune contingenze;
La temerarietà di qualcuno – che – si badi – non è coraggio, ma audacia eccessiva, sconsiderata, irragionevole;
L’incapacità, l’apatía o mancanza di “páthos”, in alcuni, la negligenza « nell’adempimento dei doveri del proprio ufficio », in altri: (“non si manda una nave allo sbaraglio, stracarica di passeggeri, sola, senza scorta, non ce se ne lava le mani, non la si lascia partire, ci si oppone, se non si vuole andare incontro a disastro sicuro…; bisognava riflettere, pensarci due volte, prima di…obbedire almeno alla legge del…buon senso; non….”).
Tutte cause o incidenze gravi, che hanno avuto un peso non indifferente nella dinamica dei fatti. Ove fosse stato possibile ridurne il malefico influsso, si sarebbe potuto almeno contenere, limitare, ridurre al minimo, le proporzioni di una “catastrofe annunciata”, che invece ebbe a costare la vita a un gran numero di persone.
Oltre 400, certamente. Forse 500. Forse anche di più.
La violenza, spesso senza volto e senza perché, era così diffusa, allora e dappertutto, che nessuno sapeva rinunciarci; e se ne ebbero i risultati!
Un vero disastro, torniamo a ripetere, una sciagura immensa, incredibile…
Non delle stesse proporzioni di quello lamentato nell’affondamento del “TITANIC” (1912), certo, o del “LUSITANIA”, il cui inabissamento, nel 1915, suscitò lo sdegno dell’opinione pubblica americana e contribuì ad orientarla in favore dell’entrata in guerra (nel 1917) degli Stati Uniti a favore dell’Intesa, ma pur sempre, enorme, raccapricciante, impressionante, che aveva chiaramente colpe ben definite.
Un disastro, nel vero senso della parola. Una strage, o carneficina se preferite.
Una tragedia che si poteva contenere, ridurre al minimo. Ma mancò l’impegno, la volontà di obbedire in pienezza di spirito e di partecipe generosità ai doveri precisi dello stato di ciascuno degli…addetti ai lavori.
Colpa anche della propaganda insidiosa che tanto male stava predicando ed inculcando, anche nei soldati di prima linea, forse! -. Mancò, infine quello spirito di solidarietà che fa grande un fratello al momento del bisogno.
E di scalpore e di impressione ne fece veramente tanta il malaugurato evento che ne rimasero giustamente preoccupati politici e militari, considerato anche e soprattutto, il grave momento in cui esso avveniva – si era, infatti, in un mese “caldissimo” della guerra in atto: nel fatale ottobre ‘17 -.
E, per far piena luce e chiarezza sulla triste vicenda e tacitare le coscienze turbate, usando prudenza, cautela e circospezione, il Ministero della Marina, aprì in tutta fretta un’ampia inchiesta: furono sentiti, in primo luogo i sopravvissuti (italiani e stranieri): i membri dell’equipaggio, gli artiglieri, i radiotelegrafisti, i passeggeri imbarcati, tutti i veri protagonisti insomma della vicenda. Furono ascoltati inoltre, come parte in causa, indiziati di reato, il Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto, il Comandante in Capo dell’Armata R.N. “ Trinacria ”, il Comandante della Divisione Base di Taranto, il Comandante della Divisione Navale dello Jonio R.N. “ Città di Catania ”, il Comandante di Spiaggia di Gallipoli, il Commissario militare del piroscafo “ Città di Bari ”.
E, dopo due mesi circa di minuziose indagini, acclarata ogni cosa e individuati i veri responsabili del disastro, il Tribunale Militare emanò la sua sentenza: inflisse le pene che ciascuno si meritava, ma con mitezza, senza infierire contro nessuno.
Le sanzioni e i provvedimenti presi restarono però nel chiuso degli uffici, ammantati di discrezione e di riservatezza, mai svelati. Solo pochi conobbero le conclusioni della Giustizia. Esse non furono mai rese pubbliche “ per l’impressione ” si disse. Come non venne mai reso pubblico il numero preciso delle persone scomparse, tutte insieme, in uno stretto braccio di mare:
morte,
a due passi dalla salvezza, pensate!
Sotto i nostri stessi occhi.
Con la nostra stessa complicità.
Come non pensare che essi, i morti, tutti quei morti, pesino, ancora oggi, sulla comune coscienza?
Le colpe, le responsabilità, stavano là e parlavano da sole e chiedevano giustizia, non vendetta, ma neppure dimenticanza.Giunse sì la giustizia, e anche presto; arrivarono le conclusioni del Tribunale, puntuali, rapide, immediate, ma non proprio eque, cioè giuste, commisurate alla gravità o levità dei reati realmente commessi, non proprio riparatrici, accompagnate, vorremmo dire, da giusto rigore morale e giuridico.
Sapevano, esse, troppo di affrettato, di condizionato, di biasimevole, di ovattato, forse di vergognoso da nascondere ad ogni costo, chiusi a doppia mandata nei ferrei cassetti degli archivi di Stato, insieme con la verità.
E le lacrime non furono mai asciugate!
Sicché, una tragedia sì grande e sì grave, lentamente, fatalmente, scivolò nel dimenticatoio. Con tutti i suoi ricordi dolceamari.
Che tristezza!
Questi i fatti, nudi e crudi. Queste le dure verità. Queste le colpe e le responsabilità acclarate dalla Magistratura, quali ci rivengono dalla lettura “a caldo” dei documenti dianzi citati e riportati. Non li ho certo inventati io e neppure manipolati o adulterati. Li ho soltanto “raccontati” in tutta la loro rapida successione, ruvida asprezza, estrema angosciosità.
Certo con la morte nel cuore per quello che stava succedendo al mio papà. Con l’animo straziato dal dolore. Con rabbia impotente. Con intensa passione e partecipazione.
Non mi si farà poi colpa grave, se, talvolta, mi è capitato di condirli, senza volerlo, con un pizzico di amara insoddisfazione, dettata, peraltro, dal mio stato di “dolente parte in causa”.
A mente fredda, invece, a mente libera dal velo della passione, questi stessi fatti, questi stessi comportamenti umani, riconsiderati più attentamente e visti alla luce di una più approfondita riflessione, assumono, possono assumere, come in un processo di decantazione, un aspetto nuovo; offrono, possono offrire una diversa valutazione e interpretazione dell’accaduto. Secondo la quale il personale della Marina Militare Italiana dislocato nel Basso Adriatico e nello Jonio, dall’ufficiale più elevato in grado al semplice marinaio, non avrebbe nulla da rimproverarsi nella triste “Historia” del “Città di Bari” e che, nel disimpegno delle proprie specifiche mansioni, tutti avrebbero operato “in assoluta buona fede” per il buon fine del pericoloso viaggio intrapreso dalla nave barese. E che, se dei responsabili del disastro c’erano, essi sarebbero da ricercare non tanto fra gli equivoci e i malintesi, fra le carenze e le omissioni lamentate o fra gli “sfilacciamenti” e le inadempienze di questo o di quello, quanto piuttosto nel “virus della discordia e della disobbedienza”, nei “veleni” della contrapposizione e della divisione, dell’odio e della violenza, che, penetrando nell’animo umano e stringendo nella morsa del contagio, tutti e ciascuno, avrebbe sconvolto anche le coscienze corazzate, le difese resistenti dei marinai italiani impegnati nella guerra.
Analisi precisa, argomentazioni giuste, verità palesi, indiscutibili, che, però non hanno la forza e il potere di dimostrare l’infondatezza delle accuse mosse e comprovate in sede di inchiesta giudiziaria; di mandare assolti i presunti responsabili della sciagura, di rendere meno gravi e dolorose le proporzioni del disastro.
Di un “caso” sì grave riesce veramente difficile, se non impossibile, diluirne nella verità il pianto ed il rimpianto di ciò che si è responsabilmente o irresponsabilmente perduto.
«Per il dono del tuo Spirito, Signore, fa che ogni condizione di paura si apra alla fiducia, ogni situazione di dolore sia illuminata dalla speranza della pasqua, ogni atteggiamento di egoismo o d’indifferenza si converta nella gioia della condivisione e del servizio verso il fratello».
«Ma, di questa immensa tragedia – si domanda a questo punto l’uomo della strada -, di tutte queste vittime innocenti dell’umana follia, che cosa ricorda oggi la memoria storica? che cosa resta di bello e di buono e di moralmente utile alla società odierna?».Era mio padre, orfano di guerra dall’età di 2 anni. Su quella nave c’era mio nonno Pasquale. Mio padre è deceduto il 6 gennaio 2014 all’età di 98 anni. Da lassù, ringrazia il direttore pro-tempore dell’Ufficio Storico della MMI, amm. Buracchia. Grazie.
(In foto mio padre è il primo a sx; io sono quello accovacciato).